
Recensione da Venezia: Pin de Fartie è una rilettura giocosa e vertiginosa di Samuel Beckett.
Dall’inizio degli anni 2000, il feroce e indipendente collettivo cinematografico argentino El Pampero Cine ha costruito una filmografia sui generis sottraendosi alle convenzioni. Un catalogo che include i 13,5 ore di La Flor di Mariano Llinás e le 4,5 ore di Trenque Lauquen di Laura Citarella non facilita certo le cose. Eppure chi si sintonizza sul ritmo di Pampero testimonierà l’esperienza singolarmente gratificante di lasciarsi andare ai loro film. Pin de Fartie, l’ultimo lavoro del cofondatore Alejo Moguillansky, si attesta su un molto ragionevole 106 minuti. Come amplia e decostruisce una delle opere teatrali assurdiste più emblematiche del XX secolo farà comunque girare la testa.
L’opera in questione è Fin de Partie (Endgame, come è noto in inglese) di Samuel Beckett del 1956. La tragicommedia sperimentale in un atto è ambientata in un’unica stanza e presenta quattro personaggi che battibeccano mentre si confrontano con la desolazione e il nonsenso dell’esistenza. Pin de Fartie si apre su una scena che ricorda immediatamente l’ambientazione dell’opera: un uomo cieco comanda il suo servitore/badante scambiando una serie di domande e risposte banali e ripetitive — eccetto che qui il destinatario della piccola rabbia del cieco (Otto) è una ragazza (Cleo). Ci si rende conto che non si tratta solo di una reinvenzione aggiornata del materiale originale quando la macchina da presa taglia su una squadra di persone che forniscono la narrazione e gli effetti sonori. Le cose si complicano quando la stessa squadra comincia a narrare “varianti” della storia di Beckett: una in cui due attori si incontrano settimanalmente per provare Fin de Partie, e un’altra in cui una donna cieca chiede a suo figlio di leggergli la pièce. Oltre alla natura metanarrativa dell’intera costruzione, i destini dei personaggi cominciano a divergere dalle loro controparti letterarie in modi inaspettati.
Essendo El Pampero Cine, non sorprende che il film sia piuttosto esoterico nella concezione e nell’esecuzione. Gli spettatori non familiari con Fin de Partie o con gli orientamenti filosofici di Beckett avranno più difficoltà a entrarci; la sceneggiatura ossessivamente prolissa (che include interi passaggi ripresi parola per parola dal testo originale) non la rende più accessibile. Eppure c’è una genuina giocosa inventiva nel modo in cui Moguillansky e le coautrici Luciana Acuña e Mariano Llinás trattano un testo settantenne sull’angoscia esistenziale. La silliness intrinseca della situazione di Otto e Cleo è sottolineata per far emergere la commedia nelle parole di Beckett. Pur percependo ancora la frustrazione dei personaggi che si sentono intrappolati e incapaci di cambiare ciò che li circonda, la pura banalità dei loro scambi fulminei (“Che ore sono?” “Quelle di sempre.”) mette a nudo l’artificiosità del mondo che abitano e inietta un tagliente sollievo comico.
Il segmento sulle prove ha un’atmosfera del tutto diversa. Nel diventare i personaggi creati da Beckett, i due attori cominciano a dubitare se i sentimenti che provano l’uno per l’altro siano veramente i loro o siano stati tutti pre-scritti. Col passare del tempo, i loro incontri settimanali si trasformano in un’esame di performance e autenticità che tocca una nota sorprendentemente emotiva.
Poi c’è forse la sezione più straniante: la donna cieca e suo figlio, in cui il figlio devoto comincia a notare parallelismi tra la storia che legge e la propria vita. Per scoprire cosa ciò significhi (e se sua madre stia cercando di dirgli qualcosa tramite Beckett) intraprende un’indagine privata sulla propria stessa esistenza. Qui, al più tardi, la selvaggia originalità che è il marchio delle produzioni Pampero brilla davvero. Dalla scoperta di un tennista che gli somiglia fino al decifrare la frase tatuata sul braccio del suo sosia, la storia prende una piega così strana da suggerire un film completamente diverso. Questa disponibilità ad abbandonare la logica e gli archi narrativi tradizionali — a lasciare entrare i piccoli misteri della vita nella narrazione — è ciò che dà a film come Pin de Fartie quella scintilla in più e permette allo spettatore di provare l’ebbrezza di assistere a qualcosa che prende il volo.
Il film scorre da un segmento all’altro e ritorna con grande fluidità, legato da scorci nello studio di registrazione dove un narratore onnisciente esercita una supervisione quasi divina sui soggetti ignari. Questo espediente narrativo trasmette con intelligenza il dominio totalitario dei narratori e aggiunge ulteriori livelli alla riflessione di Beckett sull’impotenza dell’uomo nel provocare cambiamento. Eppure Moguillansky si rivela molto meno nichilista e fatalista. L’ultimo tratto vede ciascun personaggio giungere a una sorta di realizzazione, rompendo un ciclo di dipendenza e disperazione. Fin de Partie parla in larga misura della nostra incapacità di scegliere i nostri finali. Affidando i suoi personaggi a un mondo immaginato da Beckett ma dando loro la possibilità di uscire dal copione, Pin de Fartie diventa una risposta edificante e sottilmente profonda a un testo che reimmagina abilmente per lo schermo.
Pin de Fartie ha debuttato al Festival di Venezia 2025.

Altri articoli
 Novità in streaming: Highest 2 Lowest, The Naked Gun, Friendship, Inherent Vice e altro ancora
Ogni settimana evidenziamo i titoli degni di nota che sono recentemente approdati alle piattaforme di streaming negli Stati Uniti. Consulta le selezioni di questa settimana qui sotto e i riepiloghi precedenti qui. Black Bag (Steven Soderbergh) Se un film di James Bond o Mission: Impossible eliminasse tutte le sue scene d'azione — salvo qualche esplosione o colpo d'arma da fuoco isolato — e al contempo adottasse una sceneggiatura in stile John le Carré ma in chiave pop
Novità in streaming: Highest 2 Lowest, The Naked Gun, Friendship, Inherent Vice e altro ancora
Ogni settimana evidenziamo i titoli degni di nota che sono recentemente approdati alle piattaforme di streaming negli Stati Uniti. Consulta le selezioni di questa settimana qui sotto e i riepiloghi precedenti qui. Black Bag (Steven Soderbergh) Se un film di James Bond o Mission: Impossible eliminasse tutte le sue scene d'azione — salvo qualche esplosione o colpo d'arma da fuoco isolato — e al contempo adottasse una sceneggiatura in stile John le Carré ma in chiave pop
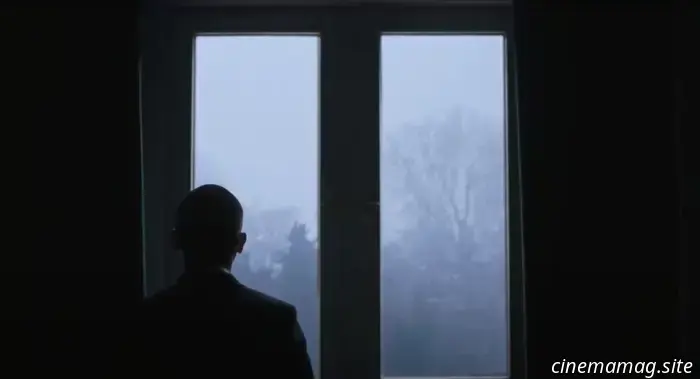 Il primo trailer di "Silent Friend" di Ildikó Enyedi unisce Léa Seydoux e Tony Leung
In una collisione di talenti internazionali che sembra diventare sempre più rara, Ildikó Enyedi ha riunito Léa Seydoux e Tony Leung per Silent Friend, che "racconta tre storie collegate a un albero nell'arco di più di 100 anni" e (piuttosto ambiziosamente) si concentra su "mutamenti radicali nella percezione umana delle piante, degli animali e degli esseri umani." In
Il primo trailer di "Silent Friend" di Ildikó Enyedi unisce Léa Seydoux e Tony Leung
In una collisione di talenti internazionali che sembra diventare sempre più rara, Ildikó Enyedi ha riunito Léa Seydoux e Tony Leung per Silent Friend, che "racconta tre storie collegate a un albero nell'arco di più di 100 anni" e (piuttosto ambiziosamente) si concentra su "mutamenti radicali nella percezione umana delle piante, degli animali e degli esseri umani." In
 Recensione TIFF: Mile End Kicks segue una critica musicale canadese che si ritrova.
C'è una ragione per cui Jagged Little Pill di Alanis Morissette risuona con Grace Pine (Barbie Ferreira). È la stessa ragione per cui la sua proposta convince un editore a concederle un anticipo e un contratto per pubblicare un libro della serie 33 1/3 sull'argomento: la rabbia femminista; l'onestà; il fatto che il mondo fosse disposto a sborsare milioni
Recensione TIFF: Mile End Kicks segue una critica musicale canadese che si ritrova.
C'è una ragione per cui Jagged Little Pill di Alanis Morissette risuona con Grace Pine (Barbie Ferreira). È la stessa ragione per cui la sua proposta convince un editore a concederle un anticipo e un contratto per pubblicare un libro della serie 33 1/3 sull'argomento: la rabbia femminista; l'onestà; il fatto che il mondo fosse disposto a sborsare milioni
 Paramount+ ha svelato il trailer della seconda stagione di Landman e le immagini promozionali.
Paramount+ ha rilasciato un trailer della seconda stagione dell'acclamata serie drammatica di Taylor Sheridan (Yellowstone), Landman. Con protagonisti Billy Bob Thornton, Demi Moore, Sam Elliott, Andy Garcia, Ali Larter, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan e Colm Feore, potete vedere il trailer della seconda stagione qui sotto… Ambientata in […]
Paramount+ ha svelato il trailer della seconda stagione di Landman e le immagini promozionali.
Paramount+ ha rilasciato un trailer della seconda stagione dell'acclamata serie drammatica di Taylor Sheridan (Yellowstone), Landman. Con protagonisti Billy Bob Thornton, Demi Moore, Sam Elliott, Andy Garcia, Ali Larter, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan e Colm Feore, potete vedere il trailer della seconda stagione qui sotto… Ambientata in […]
 Star Wars: The Clone Wars — l'action figure in scala 1/6 del Sergente Hound svelata da Hot Toys
Hot Toys ha svelato la figura da collezione in scala 1:6 del Sergente Hound, tratta dall'episodio «The Jedi Who Knew Too Much» della quinta stagione della serie animata Star Wars: The Clone Wars, che include anche una figura del suo mastino, Grizzer; guarda le immagini promozionali qui… VEDI ANCHE: Clone Commando Gregor si unisce […]
Star Wars: The Clone Wars — l'action figure in scala 1/6 del Sergente Hound svelata da Hot Toys
Hot Toys ha svelato la figura da collezione in scala 1:6 del Sergente Hound, tratta dall'episodio «The Jedi Who Knew Too Much» della quinta stagione della serie animata Star Wars: The Clone Wars, che include anche una figura del suo mastino, Grizzer; guarda le immagini promozionali qui… VEDI ANCHE: Clone Commando Gregor si unisce […]
 The Grabber è tornato dall'aldilà nel trailer di The Black Phone 2
Universal Pictures e Blumhouse hanno pubblicato il primo trailer completo del sequel horror del regista Scott Derrickson, The Black Phone 2. Il film si concentra su Finn quattro anni dopo che è scappato e ha ucciso il suo rapitore, The Grabber, quando il sadico assassino di bambini torna dall'oltretomba, tormentando la sorella minore di Finn, Gwen, mentre lei comincia […]
The Grabber è tornato dall'aldilà nel trailer di The Black Phone 2
Universal Pictures e Blumhouse hanno pubblicato il primo trailer completo del sequel horror del regista Scott Derrickson, The Black Phone 2. Il film si concentra su Finn quattro anni dopo che è scappato e ha ucciso il suo rapitore, The Grabber, quando il sadico assassino di bambini torna dall'oltretomba, tormentando la sorella minore di Finn, Gwen, mentre lei comincia […]
Recensione da Venezia: Pin de Fartie è una rilettura giocosa e vertiginosa di Samuel Beckett.
Dall'inizio degli anni 2000, il collettivo cinematografico argentino fieramente indipendente El Pampero Cine ha costruito una filmografia sui generis rifiutando le convenzioni. Un catalogo che comprende La Flor di Mariano Llinás, della durata di 13,5 ore, e Trenque Lauquen di Laura Citarella, di 4,5 ore, non rende certo le cose facili. Tuttavia, coloro che si lasciano trasportare dal ritmo di Pampero potranno testimoniare quanto sia singolarmente gratificante
